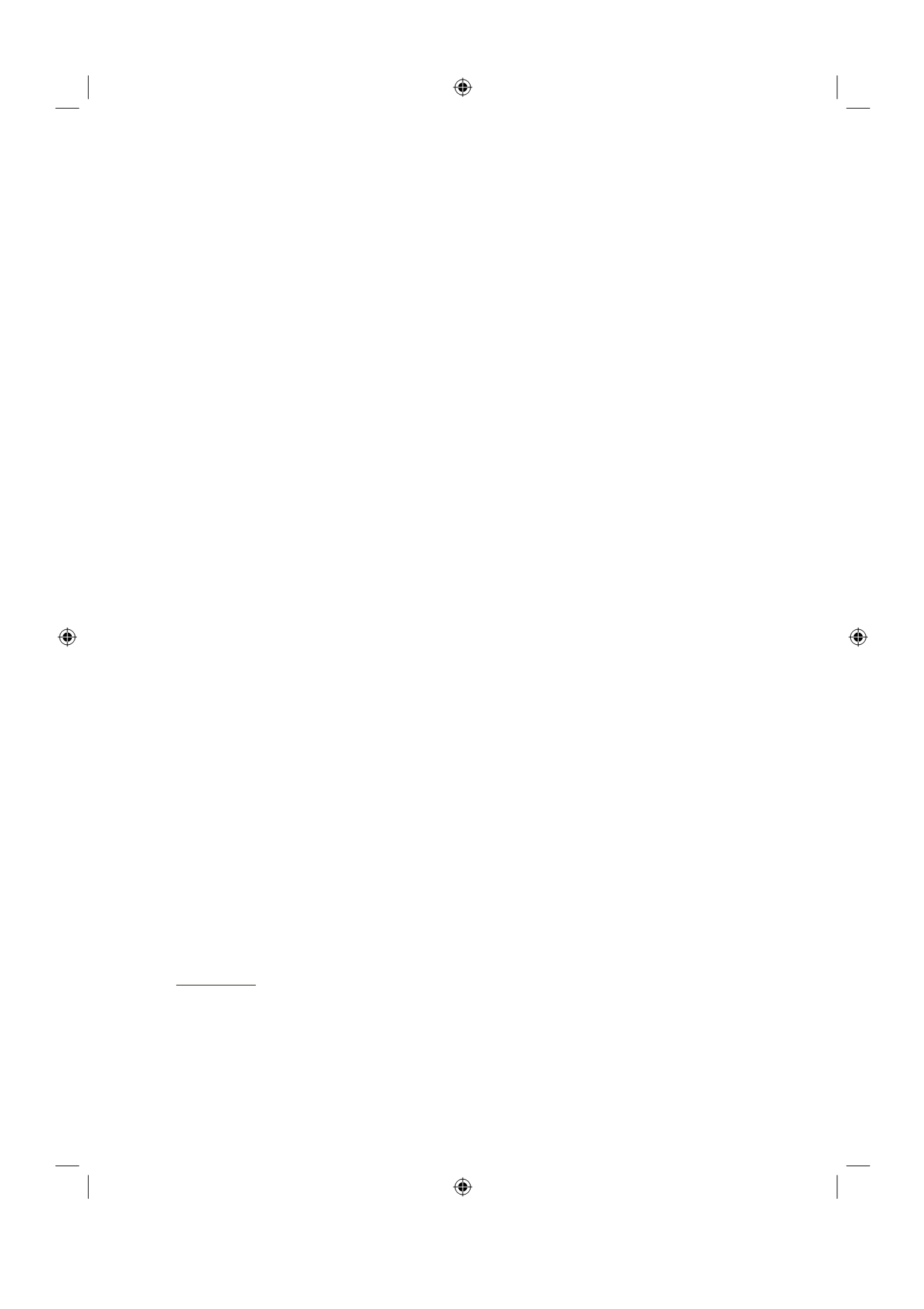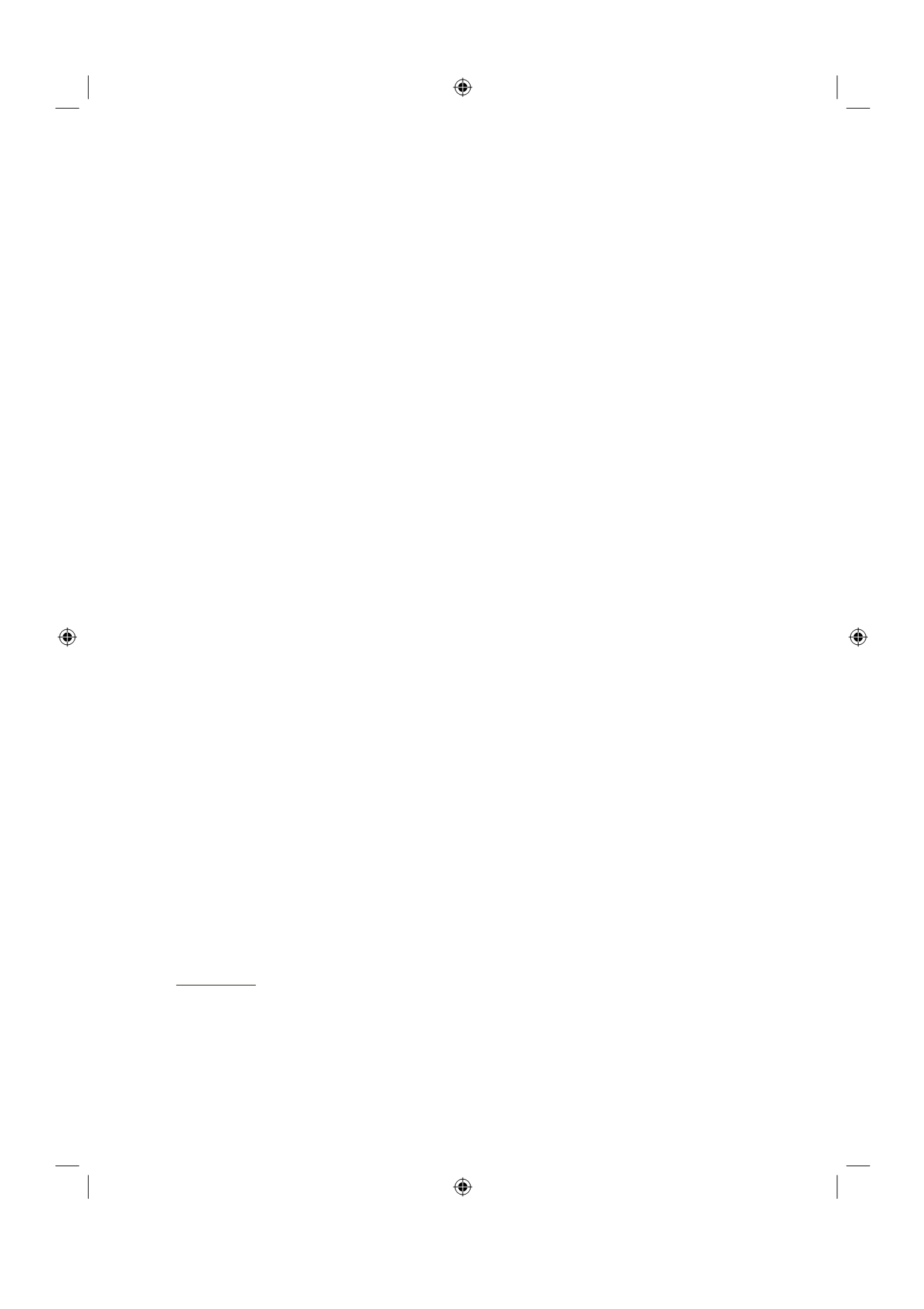
«Vecchie città ed edilizia nuova», il contributo di Ciro Contini (1873-1952)
157
Architettura nel decennio successivo, in diverse università italiane. In questi anni,
una generazione di tecnici ingegneri e architetti, allievi di una cultura accademica o
di scuole applicate, si trova a tirare le somme di una molteplicità di esperienze che
interessano l’edificio e la città, la modernizzazione di quest’ultime e l’inserimento di
edifici nuovi in contesti storici. Un processo critico che porta, non a caso congiunta-
mente, alla maturazione della disciplina urbanistica da un lato (dopo le prime espe-
rienze della seconda metà dell’Ottocento) e al sempre più consapevole e rispettoso
approccio al restauro, dall’altro. Di questo fervente dibattito Contini si dimostra uno
specchio aggiornato, consapevole dei più moderni approcci alle diverse materie, ma
non sempre in linea con questi indirizzi, radicato in posizioni e scelte urbanistiche
che lo legano a una prassi attardata. Le sue scelte sono lo specchio della sua forma-
zione, ancora spuria e molto autodidatta, come per i suoi coetanei formatisi in scuole
applicate o accademie.
In campo urbanistico, la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento
segnano in Italia una tappa importante e molto consistente nella trasformazione delle
città antiche e nel loro ampliamento, per consentire lo sviluppo demografico in par-
te in atto e in gran parte agognato dagli amministratori locali. L’arrivo delle prime
strade ferrate e lo sviluppo di piccoli o grandi poli produttivi di natura industriale
generano la speranza di una grande crescita, demografica ed economica, anche nelle
città minori, come Ferrara.
Le città vivono l’esperienza di una pianificazione moderna sul finire dell’Otto-
cento, dopo l’Unità d’Italia e la realizzazione delle primarie tratte ferroviarie, utili a
connettere i principali capoluoghi. I princìpi pianificatori che si riconoscono sono,
sostanzialmente, quelli sperimentati tra il 1853 e il 1869 nel corso dell’esecuzione
del piano del barone Georges Eugène Haussmann (1809-1891) per rinnovare Parigi,
e poi reiterati nelle principali capitali europee, quindi:
a)
sventramenti
,
19
finalizzati a risanare aree igienicamente disagiate, connette-
re le polarità della città e facilitare il crescente traffico veicolare;
b)
isolamenti
, volti a monumentalizzare gli edifici di rilievo storico-artistico,
per liberarli dagli edifici che vi si erano addossati nel corso del processo di
sviluppo della città e per creare nuove spazialità urbane, più convenienti alla
moderna borghesia, alle attività commerciali e all’industria.
Un importante esperimento di pianificazione italiano è quello del
Piano moderno
di Roma
(1883) che prevede numerosi ampliamenti esterni ma, anche, sventramenti
e isolamenti nel tessuto edilizio più antico. Nuovi assi in grado di risanare la città
vecchia, connettere i grandi monumenti con strade più ampie e che ne esaltassero la
visione prospettica, prevalentemente centrale.
Napoli, nel 1885, vive l’esperienza del
Piano di Risanamento
che, a seguito
di una forte epidemia di colera e grazie all’approvazione di una speciale legge che
permette di migliorare il calcolo dell’indennità di esproprio,
20
riesce a concretizzarsi
nei quartieri più degradati, con ampi sventramenti viari e la sostituzione totale degli
edifici esistenti. Risanamento che coprì, sotto l’ala protettiva dell’interesse pubblico,
19
Il termine sventramento lo si fa risalire alle parole del presidente del Consiglio Agosti-
no Depretis che, nel 1884, a seguito dell’epidemia di colera a Napoli dichiarò che era neces-
sario «sventrare Napoli» per risanarla, ispirandosi alla lettura de
Il ventre di Napoli
di Matilde
Serrao.
20
Legge per il risanamento della città di Napoli
del 15 gennaio 1885.
Ebrei a Ferrara 1.indd 157
07/04/14 11:42