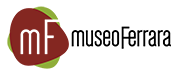Il Monastero di Sant’Antonio in Polesine

Il Monastero di Sant’Antonio in Polesine si trovava poco fuori le mura, a sud-est della città, sull’isola di Sant’Antonio in mezzo al Po di Volano. La storia del Monastero è legata alla figura della Beata Beatrice II d’Este, vissuta nel XIII secolo.
La storia di Beatrice II d’Este
Beatrice II d’Este figlia di Azzo VII d’Este e Giovanna di Puglia nacque intorno al 1226 nel Castello di Calaone sui Colli Euganei. Trascorse la sua infanzia tra i palazzi di Padova, Rovigo e la corte di Ferrara, soffrendo l’improvvisa perdita della madre all’età di sette anni e la partenza della cara cugina Beatrice III regina d’Ungheria, venuta a mancare anni dopo.
Grazie all’educazione del padre improntata alle sacre scritture e della matrigna Mabilia o Amabilia Pallavicini verso una vita di spiritualità interiore, nacque in lei il desiderio di consacrarsi totalmente a Cristo, vivendo un periodo di meditazione e solitudine nella villa di famiglia sull’isola di San Lazzaro, anticamente formata dal Po di Volano a est di Ferrara. Questa sua decisione dimostra la sua devozione a Dio e convinse il padre a consentire la sua monacazione.
Nel 1254 assieme alla damigella Meltruda, che aveva scelto la sua stessa vita, si trasferì presso il Monastero di Santo Stefano della Rotta di Focomorto dove abbracciò la Regola di San Benedetto assegnata da papà Innocenzo IV (1233-1254). Beatrice II trascorse gli ultimi anni della sua vita nel Monastero di Sant’Antonio in Polesine, acquistato dal padre Azzo VII nel 1257, dove si trasferì la comunità monastica femminile. Il 18 gennaio 1262 morí poco più che trentenne e venne sepolta in un angolo del chiostro di fianco la chiesa, dove ancora oggi è possibile visitare la sua tomba posta nella sua Cappella.
Il Monastero di Sant'Antonio in Polesine
Il Monastero di Sant’Antonio in Polesine si trovava originariamente sull’isola fluviale di Sant’Antonio posta in un punto di defluenza dei due rami principali del Po altomedievale: il Po di Volano e il Po di Primaro, fino a quando il progressivo impoverirsi del fiume scoprì la terra attorno al XIV secolo.
Prima dell’arrivo delle monache benedettine, la chiesa e il convento di Sant’Antonio Abate appartenevano ai frati eremiti di Sant’Agostino, che si trasferirono successivamente nella chiesa di Sant’Andrea a Ferrara, lasciando un luogo ideale per la preghiera e il perseguimento della vita monastica. Così dopo l’acquisto nel 1257 vennero attuati i lavori di rifacimento della chiesa e del convento attribuiti al Maestro Tigrino, il quale lasciò le tre cappelle a volta gotica, separate dalla chiesa interna, o coro delle monache, da tre archi a sesto acuto, che testimoniano l’architettura del tardo Duecento.
Gli ambienti del monastero sono caratterizzati da una chiesa suddivisa in due parti, una esterna e una interna, dal chiostro a due piani e dall’orto retrostante. Il coro delle monache è il nucleo più antico della chiesa originaria e si presenta come una sala rettangolare contornata sulle pareti maggiori dagli stalli in noce intarsiati della seconda metà del XV secolo attribuiti ai fratelli Canozzi di Lendinara. Dall’insediamento delle monache benedettine è certo che i lavori continuarono per lungo tempo.
Il monastero tra XIV e XV secolo: riconoscimenti e fasi di costruzione
La storiografia degli eventi del monastero non è lineare a causa della mancanza di fonti, contratti e testimonianze, soprattutto nella costruzione del secondo chiostro risalente al 1593.
A partire dal XIV secolo, le decorazioni della chiesa interna e delle tre cappelle absidali hanno visto all’opera un pittore emiliano-riminese di scuola giottesca per la realizzazione del ciclo di affreschi della vita di Cristo. Vengono decorate anche le pareti laterali della chiesa interna ed esterna che scomparvero a causa di successivi lavori.
Nel 1380 viene affrescato il loggiato est del chiostro da maestri della scuola di Altichiero, con una visione di paradiso e una prospettiva architettonica.
La prima metà del XV secolo è stata descritta dal Guarini (1) come periodo importante per il monastero e per la sua affermazione nel panorama locale, tanto da ricevere in soggiorno i papi Gregorio XII nel 1414, Eugenio IV nel 1439 e Pio II Piccolomini nel 1459, e la consacrazione della chiesa da parte del vescovo Pietro Boiardi nel 1413. Un’altra data importante è il 1433, persino riportata nel ciclo di affreschi della cappella centrale dell’abside, che ricorda i continui lavori e l’esecuzione della scala interna di collegamento fra la chiesa e il dormitorio.
La necessità di ampliare il monastero si protrae nel XV secolo quando risultano presenti nel monastero, tra il 1467 e il 1468, gli artigiani Magistro Guglielmo de Ronchegalo marangone e Magistro Andrea del Cossa muratore.
Il monastero tra XVI e XVII secolo: riconoscimenti e fasi di costruzione
Intorno al 1503 si ha notizia di ulteriori lavori alla chiesa interna, in particolare la decorazione dei pilastri delle Cappelle del Coro che vengono affrescati con immagini di Santi da Michele Coltellini. Ora rimane di lui S. Maria Maddalena sul pilastro della cappella sinistra, mentre i due affreschi di prospetto, rappresentanti S. Benedetto e S. Placido, recentemente restaurati, sono un rifacimento del secolo XVIII. (2). Inoltre nel primo cinquecento viene compiuto il soffitto del Coro a fornici per coprire le capriate trecentesche.
Nel 1551 la chiesa acquisisce il magnifico organo costruito dal Cipri, che verrà perduto negli anni a seguire con l’invasione di Napoleone. Alla fine del secolo, nel 1593 iniziano i lavori per il secondo chiostro, collocato ad ovest del più antico, che non riporta alcuna decorazione visibile a causa delle gravi manomissioni subite, ma si deduce che il loggiato fosse decorato con stemmi ancora leggibili fino a pochi anni fa nella parte superiore delle pareti interne. Una testimonianza interessante per ricostruire la storia e l’evoluzione, ci è data dal libro delle spese del monastero (3) che riassume il costo dei lavori e degli interventi all’anno 1621 rivolti alla fabbrica del refettorio e al riammodernamento degli ambienti.
Il monastero tra XVIII e XIX secolo: riconoscimenti e fasi di costruzione
Se tra XVII e XVIII si respira armonia e benessere, riscontrata anche dal materiale archivistico che riporta un’ottima amministrazione dei beni e della gestione interna alle attività del monastero, nel corso del Settecento si affrontano difficoltà e rivolte. Nel 1796 i francesi guidati da Napoleone Bonaparte, durante la campagna d’Italia, saccheggiarono il monastero impadronendosi dell’altare maggiore in legno dorato, del tabernacolo, di tutta l’argenteria liturgica, dei quadri di autori stimati e delle pergamene d’archivio. Come conseguenza si pensò alla chiusura della chiesa ma già nel 1798 la tenacia delle monache venne ripagata con la riapertura e l’acquisto di un nuovo organo costruito dal Fedeli nel 1795. Quello precedente passò al Demanio.
Persino nell’Ottocento si affrontarono difficoltà e ingiustizie come nell’anno 1866, quando il governo sabaudo soppresse gli Ordini religiosi, impossessandosi dei beni e delle rendite sancendo l’espulsione dai conventi, lasciando le trentotto monache di Sant’Antonio con una misera pensione. Nel 1870 sono la benedizione della beata Beatrice e quella di San Benedetto nel 1880 a rianimare il monastero con le celebrazioni e i restauri della chiesa e della cappella della Beata su progetto del Barbantini.
Il monastero nei primi anni del Novecento
Nel 1910 una parte del cenobio passa nelle mani dello Stato che lo adibisce a caserma, mentre il Fondo Culto vende al Comune di Ferrara le due ali orientali e settentrionali del chiostro, la chiesa, l’orto e il sagrato con i fabbricati annessi. Subito la Curia Arcivescovile di Ferrara ottiene dal Comune l’affitto di quei locali, disponendoli ad uso delle benedettine. (4).
L’uso dei locali in questi anni cambia, perché lo stato di conservazione degli ambienti ne impedisce l’abitazione; nel 1934 si restaurano la facciata della chiesa esterna e il grande nartece del XV secolo mentre nel 1941 la Sovrintendenza delle Belle Arti inizia il restauro degli affreschi nella chiesa interna. La seconda guerra mondiale, invece, costrinse le monache a lasciare il convento provvisoriamente, consentendo il loro ritorno diversi anni dopo quando vennero intrapresi lavori di miglioramento.
Note
1) Marco Antonio Guarini, storico e letterato italiano, vissuto tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento. Nel 1621 scrisse Compendio Historico dell’origine, accrescimento, e prerogative delle Chiese, e i luoghi Pii della Città, e i Diocesi di Ferrara
2) Faustino Mostaro, Il Monastero di Sant’Antonio in Polesine: Cenni storici, Ferrara, 1978, pp. 38
3) Il documento è trascritto in Costanza Cavicchi, Il secondo chiostro del monastero di S. Antonio in Polesine, in Chiara Guarnieri, a cura di, Sant’Antonio in Polesine. Archeologia e storia di un monastero estense, pp. 39-49
4) Faustino Mostaro, Il Monastero di Sant’Antonio in Polesine: Cenni storici, Ferrara, 1978, pp. 46
Bibliografia
- Mostaro, Faustino, Il Monastero di Sant’Antonio in Polesine: Cenni storici, Ferrara 1978
- Artioli, Angela, Il Monastero di S. Antonio in Polesine, Ferrara: Industrie grafiche, Ferrara 1996
- Guarnieri, Chiara (a cura di), S.Antonio in Polesine: Archeologia e storia di un monastero estense, All’Insegna del Giglio s.a.s., Firenze 2006
- Dalla Negra, Riccardo, Ippoliti, Alessandro, La città di Ferrara: Architettura e Restauro, GBE Ginevra Bentivoglio EditoriA, Ferrara 2012